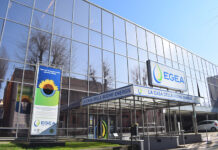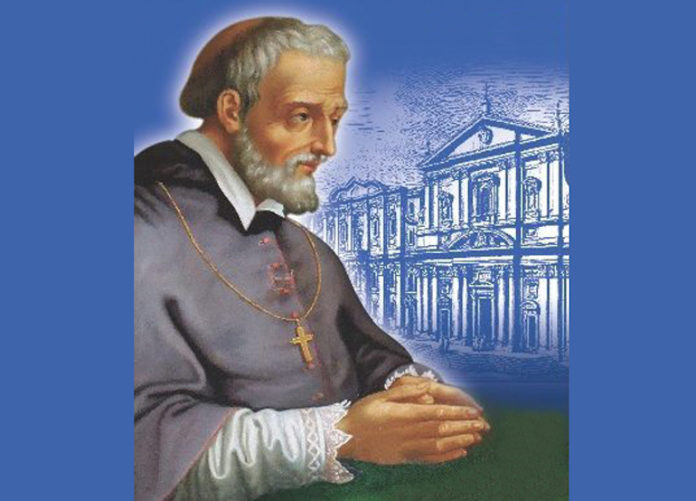Ordinato vescovo il 1° settembre 1602, mons. Giovenale Ancina deve attendere fino al 5 marzo dell’anno successivo prima di poter entrare in diocesi, per le solite questioni sulla nomina dei vescovi che in questa epoca sono ricorrenti tra i signorotti locali e la Santa Sede. Trascorre questi mesi a Fossano, lasciando intravvedere quale sarà il suo stile pastorale e indirizzando dalla nostra città il suo primo messaggio ai saluzzesi che diventa un po’ il suo “manifesto episcopale: “Procureremo di visitare gli infermi, consolare gli afflitti, sollevare i bisogni dei poveri secondo le nostre forze”, promettendo di voler “dialogare con tutti in udienze facili e pronte” e di amministrare la giustizia temperando il rigore con equità e dolcezza. Perché però non siano “promesse da mercante” le traduce subito in gesti concreti e coerenti. A cominciare dal mobilio che si porta dietro, ridotto al minimo essenziale, e al suo stile di vita, tradotto in una mensa semplicissima (cui “mai mancò di invitarvi ogni giorno almeno due poveri, e quattro nei giorni festivi”) e in un alloggio composto dalle stanze più disagevoli di tutto il palazzo. Giovenale sarà vescovo di Saluzzo per appena pochi mesi: giusto il tempo per rimettere un po’ di ordine, rinvigorire la fede, introdurre la pratica delle Quarantore, favorire il culto all’Eucaristia, combattere l’eresia che dalla vicina Francia sta dilagando in Piemonte, dare inizio alla visita pastorale di tutto il territorio di sua competenza. Inaugura un nuovo stile episcopale, sostituendo il modello del vescovo-principe, molto comune nel XVI secolo, con quello del vescovo-pastore buono, in piena sintonia con lo stile evangelico: a chi vive con lui, compreso un mendicante conosciuto a Roma e portato a Saluzzo, chiede un tenore di vita molto simile al convento e che per certi versi richiama la scelta di papa Francesco di vivere a Casa Santa Marta.
Sobrietà, penitenza, profonda pietà, austerità di vita, grande generosità verso i poveri, delicatezza e premure verso i malati: è questo il modo con cui, precedendo con l’esempio, cerca di moralizzare il suo clero e di ammaestrare il suo popolo. Non mancando, se necessario, di fare anche la voce grossa e di comminare sanzioni, come fa pochi giorni dopo il suo ingresso in diocesi, sospendendo dal ministero della confessione tutti i sacerdoti, ad eccezione dei parroci, e riservandosi di nominare solo quelli che se ne fossero resi degni. Nel suo essere cristiano e nel suo farsi pastore gli sono di modello San Filippo Neri, alla cui ombra si è formato, San Carlo Borromeo, suo contemporaneo, e san Francesco di Sales, che da Ginevra viene a Carmagnola, apposta per incontrarlo e confrontarsi con lui. Intanto predica, con lo stile che gli ha trasmesso San Filippo Neri: in chiesa, per strada, anche su una pista da ballo durante una festa patronale. E prega: ore e ore ininterrotte davanti all’Eucaristia, o nella sua camera davanti all’immagine della Madonna, così assorto e devoto che per richiamarlo alla realtà a volte occorre scuoterlo non poco. Se dall’ordinazione sacerdotale in poi ha sempre avvertito l’onere che gli deriva dal ministero, maggiormente ancora lo sente dal suo essere vescovo, tanto da non aver paura di definirlo, in una delle sue composizioni poetiche, “pastoratograntravaglio”.
Muore il 30 agosto 1604, a due anni esatti dalla sua nomina episcopale ed a 17 mesi appena dal suo ingresso in diocesi, e la sua fine è avvolta dal mistero: fu avvelenato da chi non condivideva la sua azione riformatrice e il suo zelo apostolico? I sospetti cadono su un frate, cui il vescovo Ancina pochi giorni prima aveva rinfacciato la condotta immorale e minacciato sanzioni canoniche, che gli serve un misterioso vino il giorno di San Bernardo (20 agosto), durante il pranzo che i frati del convento di Saluzzo gli hanno organizzato. Fatto sta che i disturbi nel vescovo cominciano a manifestarsi subito dopo pranzo e muore dieci giorni dopo, tra dolori lancinanti. Nessuno ha interesse o vuole approfondire subito quel sospetto e su tutto viene steso un velo pietoso, per non suscitare un vespaio, a disonore del convento. Ma la conferma che ci sia del vero in questo presunto “giallo” viene proprio dalla Postulazione, che in un primo tempo cerca di impostare la causa di beatificazione dimostrando il martirio dell’Ancina “per il veleno datogli per adempiere agli obblighi suoi episcopali”. Ovvio che non ci riesca: per il troppo tempo trascorso, per le mancate indagini effettuate a tempo debito, per la scomparsa degli eventuali testimoni e perfino per la mancanza del nome del sospetto assassino. Ciò non impedisce tuttavia a Giovanni Giovenale Ancina di giungere ugualmente alla gloria degli altari per l’ordinaria via del riconoscimento dell’esercizio eroico delle virtù cristiane, sancito dalla beatificazione avvenuta il 9 febbraio 1890 per bocca di papa Leone XIII. Mentre lui, non dimenticandosi di essere stato medico, continua a prendersi cura di quanti gli affidano i propri malanni, come testimoniano le numerose relazioni di grazie ricevute.
(2-continua)